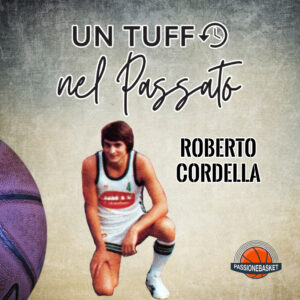Uno come lui lo vorrei sempre nella mia squadra ideale. Dotato di un tiro micidiale, soprattutto dalla grande distanza, che scagliava con successo soprattutto nei momenti topici del match. Rimanevo abbagliato dalla sua capacità di entrare in trance agonistica. Faceva la faccia cattiva, sembrava dire ai compagni “passatemi la palla, che ci penso io”. Non era un atteggiamento da sbruffone. L’ariete da Spresiano” le partite le decideva con i fatti.
Tra i simboli di quella Milano pigliatutto collocata tra l’alba ed il tramonto dei ruggenti anni 80. Cinque scudetti, due coppe campioni, una intercontinentale, una Korac e due coppa Italia. Un’altra Korac la vinse a Roma nel 1992, nella finale tutta italiana contro Pesaro. In nazionale, bronzo agli europei di Stoccarda nell’85, argento a quelli di Roma nel 91. Ero presente al PalaEur, quando uno dei suoi tiri impossibili ci consentì di battere la Grecia nella partita d’esordio.
Per gli amici di 𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝑩𝒂𝒔𝒌𝒆𝒕 ecco allora la mia intervista a Roberto Premier. Buona Lettura!
D.) L’avversario più rognoso affrontato?
R.) “Domanda alla quale mi risulta impossibile rispondere. Bisognerebbe riempire interi capitoli di un libro. Posso dire che in diciotto anni di Seria A, nazionale inclusa, ho avuto l’onore ed il piacere di giocare insieme o contro campioni e squadre che hanno segnato la storia del basket mondiale. A dire il vero, sarei in difficoltà ad elencare anche gli ipotetici meno forti, dal momento che non credo di averne mai trovati”.
D.) Esiste un aspetto che le manca del suo basket?
R.) “Il modo di concepire la pallacanestro è palesemente mutato. La predominanza del fisico a discapito della tecnica pura è abbastanza acclarata da anni. Inoltre, il gioco è più frenetico e basato sull’individualismo, con meno soluzioni generate dal gioco di squadra. Ma l’aspetto che sta scomparendo con maggior evidenza è il sano campanilismo. Non esistono più quei giocatori simbolo di una squadra o di una città. Gli stessi appassionati sono disorientati di fronte ai continui cambiamenti di un roster”.
D.) Quando ha preso confidenza con la palla a spicchi?
R.) “Alle scuole elementari, avevo nove anni. Notai un volantino che pubblicizzava corsi di minibasket. Coincidenza volle che mio padre mi chiedesse quale sport intendessi praticare. Gli risposi senza indugio che volevo giocare a pallacanestro. Ho fatto la trafila a Treviso, arrivando fino alla serie B. Nelle successive tre stagioni ho milito nella Gorizia, sponsorizzata Pagnossin.”.
D.) Quali ricordi le suscita il periodo goriziano?
R.) “Sicuramente porto con me ricordi bellissimi. Misurarmi a vent’anni con le difficoltà della neonata serie A2, ed essere lanciato in campo insieme ad altri coetanei si rivelò fondamentale. Ebbi la fortuna di essere allenato da Jim McGregor, un coach che ci lasciava liberi di assecondare il nostro istinto, senza gravarci di eccessive responsabilità. Per di più, ebbi l’opportunità di crescere in una piazza appassionata, dove la gente, compreso chi abitava in provincia, amava ed ama la pallacanestro. Il palazzetto era sempre pieno, la partecipazione numerosa anche agli allenamenti. Sono stati anni esaltanti, conditi da una promozione in serie A1”.
D.) Anni che vedono il giovane Premier mettersi in luce al punto da suscitare l’interesse dell’Olimpia Milano. Cosa aveva di speciale quella squadra, da vincere così tanto?
R.) “Affermare che fossimo un’autentica famiglia può apparire retorico, ma rende perfettamente l’idea del clima che si respirava in quel contesto. Qualsiasi giocatore nuovo arrivasse, italiano o straniero che fosse, si trovava in un gruppo consolidato, quindi il suo inserimento risultava facilitato. Facevo parte di un meccanismo perfetto, che aveva come filosofia di base il gioco di squadra. Ognuno di noi sapeva esattamente cosa fare. Senza un assist perfetto di D’Antoni, o un blocco monumentale ed un rimbalzo di Meneghin non avrei mai potuto avere la possibilità di tentare di segnare. Coach Peterson si fidava ciecamente di ognuno di noi. Anzi, si arrabbiava con me se rinunciavo a tirare. Ho vissuto a Milano un’avventura incredibile”.
D.) La vittoria alla quale è maggiormente legato?
R.) “Anche qui è arduo sceglierne una. Sicuramente vincere lo scudetto al primo anno è stato fantastico. Ma forse il Grande Slam centrato nel 1987 racchiude il top della mia carriera. La coppa di Campioni di quell’anno fu speciale. La vincemmo a Losanna, al termine di una partita durissima con il Maccabi. Quel titolo continentale fu innanzitutto caratterizzato dalla mitica rimonta operata nei quarti ai danni dell’Aris di Salonicco. Recuperammo un -31 quando tutti o quasi ci davano per spacciati”.
D.) Lei è famoso soprattutto perché la mano non le tremava nei momenti clou.
R.) “Una mia peculiarità è sempre stata l’incoscienza cestistica. Non mi rendevo neanche conto di quello che facevo. Nel senso che tenevo il medesimo atteggiamento sia in avvio che in un fase cruciale della partita. Se a pochi secondi dalla fine mi capitava di avere un buon tiro, non stavo lì a pensarci. Ma ribadisco, tutto ciò non sarebbe mai accaduto se non avessi avvertito la fiducia di compagni ed allenatore”.
D.) Ha qualche rimpianto?
R.) “La sconfitta patita dal Canada ai quarti delle Olimpiadi di Los Angeles 1984 era evitabile. Vincendo, ci saremmo giocati l’accesso alla finale affrontando una Jugoslavia non trascendentale. Magari avremmo perso dagli americani, ma intanto l’argento lo avremmo messo la collo”.